Pasta, la semplicità alimentare di una complessità culturale
Ma cos’è la pasta e che cosa ha di specifico questo versatile alimento sulle cui più antiche origini si sono dibattute dispute a non finire volte ad assegnarne il merito dell’invenzione?
Ernesto di Renzo is Cultural anthropologist at Tor Vergata University in Rome, where he is currently coordinator of the master degree in "Food culture and culinary traditions".
E pluribus unum
Conchiglie, lombrichi, bruchi, lucciole, lumache, galletti, farfalle, cannolicchi, bassotti, sorcetti, topini, vermicelli, vipere cieche. Ebbene no, queste citate in elenco non sono le denominazioni di un campionario zoologico che contraddistingue gli ambienti vegetativi, campestri e marini dell’Italia. Bensì una parzialissima ed esemplificativa lista delle circa 1.300 voci enciclopediche in cui sono state raccolte e rubricate le più diffuse tipologie di pasta nazionale. Tipologie variamente assaporate da milioni di consumatori di varia provenienza e connotazione ceto-anagrafica che sentono il quotidiano bisogno di saziare la fame optando tra scialatielli e rigatoni, sugeli e fusilli, cecamariti e bucatini, malloreddus e fusilli, penchi e penne. Tutto secondo tradizione, tutto secondo identità, tutto secondo inappagabile spirito di curiosità. Sì, perché se c’è una cosa che più di ogni altra si ricerca nel consumare i pasti questa è proprio la volontà di fare esperienza del diverso; di fuoriuscire da un ordinario mangereccio che sente periodicamente il bisogno di essere trasgredito, cambiato o addirittura superato. Foss’anche con il semplice cimento del cucchiaio e della forchetta.
Ma cos’è la pasta e che cosa ha di specifico questo versatile alimento sulle cui più antiche origini si sono dibattute dispute a non finire volte ad assegnarne il merito dell’invenzione?
Secondo la normativa che ne disciplina la produzione e il commercio:
La pasta è il prodotto di una catena di operazioni tecniche su scala domestica, artigianale o industriale applicata a una miscela di farina di grano tenero o semola di grano duro con acqua, o altra sostanza più o meno liquida, che permetta di ottenere un impasto da ritagliarsi in piccole forme regolari, e da cuocersi con calore umido […] in acqua bollente. (S. Serventi, F. Sabban, La pasta. Storia e cultura di un cibo universale, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. XII).

Questa definizione merceologica della pasta, còlto nella sua essenzialità espositiva chiarisce fondamentalmente una cosa: e cioè che affinché il prodotto ottenuto dalla lavorazione dell’impasto di farine possa definirsi pasta non occorre considerarne le materie prime o le qualità organolettiche. Occorre invece che la sua cottura avvenga esclusivamente mediante l’impego di calore umido. Un calore generalmente raggiunto con acqua ma che, a seconda delle tradizioni locali, può essere ottenuto anche con brodo, latte, vino o quanto di liquido e bollente serva a modificare le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto immerso. Se non c’è un liquido che bolle quello che si ottiene dalla lavorazione e dalla cottura della miscela di farine non può definirsi pasta. Ciò spiega (spiegherebbe) la ragione per la quale, pur trovando menzione nei documenti risalenti all’antichità ebraica, greca, etrusca e romana, molti prodotti a base di sfoglie di farina, cotti a calore secco e genericamente ricompresi nel termine lagane (làganon in greco, lagànum in latino), non sono da ritenersi pasta in senso stretto. Ma questi sono cavilli da storici, filologi, lessicologi e, volendo, da gastronomi con il pallino per le coerenze documentaristiche.

Quello che qui interessa riflettere, nel voler comprendere le ragioni del suo successo culinario e commerciale a livello planetario, è che la pasta non è un alimento da contenersi entro gli enunciati di un disciplinare di produzione. Al contrario è molte cose combinate assieme. È cibo che sazia, è cibo che nutre, è cibo che appaga, è cibo che stupisce, mettendo a disposizione dell’esperienza gustativa un’infinità di varianti da destinarsi ai condimenti più ordinari o temerari: dal burro al ragù, dall’aglione alla genovese, dalla salsa di pomodoro alla panna, dal pesto alla béchamelle, dal frizon alla carbonara, dalla marcundela alla sardella, dal picchiapò al garofolato e ad altri centinaia di maritamenti pronti ovunque a essere replicati, modificati, osannati, dismessi.

Da questo punto di vista non è fuori misura considerare la pasta come una vera e propria scatola nera idonea a registrare le tendenze in atto nei differenti luoghi geografici e negli alterni momenti storici. In pratica una sorta di display “mangereccio” attraverso cui conoscere più da vicino i gusti e i disgusti alimentari e decifrarne le mutevolezze di avvicendamento. Si pensi, ad esempio, alla fortunata auge avuta dalle paste glutinate, poliglutinate e iperglutinate che, per oltre un secolo e fino agli anni del boom industriale, hanno alimentato lo stomaco e l’immaginazione di una Italia sempre alle prese con le ristrettezze economiche e la denutrizione cronica. Ebbene di fronte al successo delle paste additivate tutto proteso al perseguimento della modernità alimentare, la contemporaneità ha posto come contraltare una costellazione di valutazioni etiche di segno completamente opposto. Valutazioni che hanno elevato le paste gluten free al rango di “buono da mangiare” e lo stile di vita semplice, sano e naturale a quello di “buono da pensare”. Uno stile che concepisce il consumo di pasta come una “controriforma alimentare” capace di librarsi indennemente tra i rigidi dettami della dieta vegetariana, vegana, dissociata e metabolica. Ma non di quella paleolitica, che evidentemente non è in grado di includere questo tipo di alimento, o di quella crudista, che renderebbe particolarmente difficile la digestione della componente amidacea presente al suo interno.

Un cibo per tutti
L’essere un cibo ad alta performabilità di preparazione e di consumo non basta a definire la pasta nella molteplicità delle sue prerogative. Essa, infatti, al cospetto di chi ne fa esperienza fagica, è assai più di un nutrimento o di una mera categoria merceologica. È creatività (soprattutto femminile) al servizio del fabbisogno. È varietà capace di intervallare la monotonia del mangiare. È ludicità da praticarsi sulla tavola a dimostrazione che l’uomo non mangia solo per sostentarsi, bensì per soddisfare innumerevoli necessità che appartengono alla sfera delle emozioni, dei sentimenti e delle identità. Quelle stesse identità che, guizzando dai passaporti ai piatti e coagulandosi attorno a simboli forti del vissuto collettivo, permettono di stabilire granitiche connessioni tra i malloreddus e la Sardegna, i tajarin e il Piemonte, i fidelini e la Liguria, i mignaculis e il Friuli-Venezia Giulia, le orecchiette e la Puglia, i maccheroni alla chitarra e l’Abruzzo. Ma anche, salendo di scala, tra i somen e il Giappone, i lamian e la Cina, i reshteh e la Persia, gli spätzle e la Baviera, i varenyki e l’Ucraina, i rezanci e la Bosnia, i jap che e la Corea, i bành canh e il Vietnam. E, va da sé ribadirlo, gli spaghetti e l’Italia.

Davvero un cibo universale, dunque, adatto non solo a soddisfare gli appetiti onnivorici del sapiens, ma anche a sapersi coniugare con i differenti contesti ambientali, economici, agronomici e culturali espressi dai vari luoghi della terra. E così dal Mediterraneo alla Cina e dal vecchio al nuovo mondo, la pasta ha saputo trarre spunto dalle più differenti tipologie di materie prime - miglio, patate, riso, grano duro, grano saraceno, farro, grano saraceno, canapa, orzo, fagiolo mungo, alghe, mais, castagna, tapioca, patata, fagiolo mungo, soia - per soddisfare gli appetiti di persone assai dissimili per abbienza e ceto di appartenenza. Difatti, se da una parte ha rappresentato il cibo popolare per eccellenza, adeguato a nutrire e far godere miriadi generazionali di contadini, braccianti (pastori un po’ meno), marinai, operai, artigiani, impiegati e lavoranti di qualunque specie, dall’altra ha trovato favorevole accoglienza nelle cucine delle classi aristocratiche, intellettuali e borghesi, dotandosi di ripieni di ogni genere e lasciandosi accompagnare dai condimenti più originali, costosi e raffinati. Così, se da un lato le testimonianze iconografiche ci documentano la visione delle Little Italy fine-ottocentesche ridondanti di giovani immigranti che trangugiano avide manate di spaghetti privi di condimento, dall’altra ci forniscono l’immagine di suntuosi saloni rinascimentali animate da nobili genti che ingozzano porzioni non meno avide di maccheroni e vermicelli. Sebbene conditi al “butirro cannella zuccaro et formaggio” e sebbene avvoltati con eleganti forchette a due rebbi.

Cibo popolare, cibo colto, cibo borghese, cibo aristocratico. In pratica, la pasta sembra incarnare quella polisemicità di funzioni che la rendono, per dirla con linguaggio da aula universitaria, “un significante che rinvia a significati del tutto estranei alla materialità dei suoi ingredienti e ai tecnicismi della sua preparazione”. Un significante dalle fisionomie flessibili e discontinue che, lungi dal lasciarsi ingabbiare in cliché tipizzati di consumo e di consumatori, ha modificato costantemente i suoi connotati esprimendosi volta per volta come cibo dell’abbienza, della frugalità, del quotidiano, della festa. Senza mai perdere, tuttavia, quella sua intima prerogativa che lo rende cibo dell’inclusione, della familiarità e dell’amicizia. Una prerogativa che nella velocità esecutiva delle “pennetta all’arrabbiata” e nella gustosa piccantezza degli “spaghi all’aglio olio e peperoncino” esprime il formidabile (e calorico) potere di tessere relazioni, rinsaldare legami, connettere esperienze, dare significato al tempo.

Monogenesi o poligenesi?
Molto si è discusso sul luogo di origine della pasta, individuandone di volta in volta l’epicentro in questa o in quella determinata parte del mondo e riferendone il merito a questa o a quella determinata cultura umana. La vexata quaestio, dibattuta con alterne tesi e differenti motivazioni, ha visto prevalere due orientamenti tra loro distinti e contrapposti: quello della monogenesi (un solo luogo di origine) e quello della poligenesi (più luoghi di origine distinti e distanti tra loro). Entrambe le prospettive sono dotate ciascuna di propri fondamenti scientifici, di propri percorsi di ricerca e di propri sostenitori o detrattori animati da spirito di parte, vista l’importanza della posta in gioco. Una posta che non è solo di natura economica e commerciale, ma anche e soprattutto identitaria e nazionalistica.
Poter infatti rivendicare la paternità della pasta, sotto questo punto di vista, non significa solo accreditarsi come i legittimi detentori di un marchio, di un’invenzione o di un brevetto. Al contrario significa riconoscersi, ed essere riconosciuti, come i brillanti creatori di un’idea geniale la cui importanza è sancita dai gusti di un intero pianeta. Roba importante, insomma. Roba che scotta, quasi quanto la temperatura richiesta dal suo servizio in tavola. Ma tornando al discorso delle origini, sembra che a considerarsi storicamente più plausibile debba essere proprio l’interpretazione poligenetica. La pasta, cioè, per la sua intuitività di concetto, per la sua facilità di realizzazione, per la sua varietà di materie prime utilizzabili e per la sua idoneità a sfamare miriadi di persone in condizioni minime di sopravvivenza, non può che avere avuto una nascita plurima e autonoma in diverse aree del pianeta. Di queste, una è sicuramente la Cina, l’altra è invece l’ampio settore geografico che abbraccia il bacino del mediterraneo fino ad estendersi alle aree del Vicino Oriente. Non una nazione precisa, dunque, ma un’estesa porzione di territorio dotata di un’omogeneità di fondo contrassegnata dalla cerealicoltura e dalla sedentarietà insediativa. Scrive appropriatamente Corrado Barberis nella sua introduzione all’Enciclopedia della Pasta edito dalla casa editrice Agria nel 2004: «L’origine della pasta non è italiana, non greca, non ebraica, non araba. Essa si trova diffusa in tutta l’area mediterranea ad uno stadio che potrebbe definirsi endemico»

Al riguardo, come hanno dimostrato con inappuntabile piglio documentativo Serventi e Sabban nella loro monografia dedicata a questo cibo universale, se stabilire con esattezza cronologica la sua adozione da parte umana non è cosa semplice, quello che risulta tuttavia ovvio è riconoscere la sua origine plurima. La storia della pasta è infatti una matassa da cui fuoriescono molteplici capi e nel cui groviglio alberga (con verità, fantasia e necessità del marketing) un po’ di tutto: dal taoismo alla dieta mediterranea, dagli Ebrei agli Arabi, dai Greci ai Romani, dai Siciliani ai Genovesi, dai Napoletani ai Garibaldini, da Marco Polo a Thomas Jefferson. Un groviglio trasudante inventiva e miglioramenti tecnologici di cui sono testimonianza i molteplici strumenti che l’uomo ha realizzato via via che i consumi alimentari tendevano a diffondersi. Si consideri al riguardo l’efficace apparato con cui già nel XII secolo gli arabi di Sicilia producevano la loro pasta secca (triyah) in territorio di Trabbia. Si considerino le ingegnose invenzioni della gramola a stanga, della gramola di capra, del torchio a vite verticale, delle trafile in bronzo e della laminatrice che dalla Napoli seicentesca iniziano a diffondersi verso la Toscana, la Liguria, Il Veneto e la Puglia fino a rendere la produzione della pasta una vera e propria professione specialistica capace di evolvere da speronelle e carraturi fino ad arrivare alle attuali e ipertecnologiche stampati 3D in grado di estendere ad infinitum le tipologie di pasta pensabili per gli appetiti e le curiosità dell’uomo.

La pasta globalizzata
In ultimo una considerazione. Oggi si parla e si scrive molto di globalizzazione, di mondializzazione dei mercati e di standardizzazione dei gusti. E soprattutto lo si fa adottando spesso toni non neutrali di giudizio che oscillano dalla disapprovazione al rammarico e dalla critica al nostalgismo di una perduta età dell’oro in cui ogni parte del mondo era diversa dalle altre. In realtà le cose sono più complesse di quello che appaiono, che vengono descritte o che vengono dibattute sui media. Se la globalizzazione è infatti da concepirsi come una con-fusione di modelli culturali inizialmente autonomi e originali, o come una volontà di far convergere ogni diversità verso forme predefinite di omogeneità, allora da disapprovarsi non è solo quanto accade sotto il cielo dell’oggi, ma anche quanto accaduto in passato all’ombra del predominio persiano, tartaro, celeste, romano e magno-greco. Tutti progetti politici volti a unificare le diversità, a diffondere credi, ad agglutinare le culture e a far circolare le merci su scale di mercato assai più ampie di quelle locali.
La globalizzazione è un fatto di sempre (cambiano ovviamente solo le velocità e le intensità di propagazione) e concepire come un fenomeno contemporaneo carico di risvolti totalmente negativi significa guardare con sguardo miope a una processualità che ha (da) sempre accompagnato la storia dell’uomo. E la pasta, cosa c’entra la pasta in tutto questo discorso sulla globalizzazione? C’entra molto. Come infatti l’evidenza ci comunica la pasta è un cibo ubiquitario che, partendo da incerte origini geografiche, ha assunto i tratti del prodotto globale e transculturale. Un alimento basico capace di prestarsi alla più ampia diffusione geografica e di adattarsi alle più disparate aspettative del gusto. Aspettative di volta in volta propendenti verso il più o meno dolce, il più o meno salato, il più o meno lungo, il più o meno sottile, il più o meno crudo. In quest’ultimo caso individuando in Napoli, e nella sua lunga storia pastaia, il ‘meridiano zero’ di una pratica di cottura che vorrebbe lo spaghetto così al dente (o al chiodo) da scolarsi quasi rigido prima di essere adagiato in un giaciglio di umida pummarola e di profumato basilico.




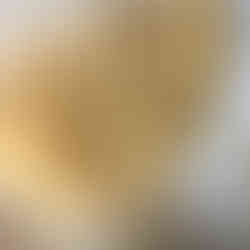









コメント